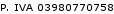Risarcibilità degli interessi legittimi
La risarcibilità degli interessi legittimi: profili processuali e tutela sostanziale
Il principio della risarcibilità degli interessi legittimi, sancita per la prima volta dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 500/99, costituisce l'espressione più evidente della crisi evolutiva che ha investito sia la nozione di interessi legittimi sia il concetto di diritto amministrativo.
Quest'ultimo, pur conservando indubbi profili di specialità, connaturati al significato stesso di funzione pubblica quale cura di interessi pubblici, si va sempre più affrancando dall'originaria accezione di diritto speciale di una funzione pubblica che, in quanto tale, deve godere di un suo ampio margine di specialità e privilegio, deve svolgersi in un'area riservata sottratta all'interferenza paralizzante di altri poteri e deve, soprattutto essere assistita dai crismi dell'imperatività ed esecutività; per contro, si va sempre più affermando una concezione del diritto amministrativo fondata sul pluralismo istituzionale e sull'esercizio di compiti pubblici non in forza del principio di autorità dell'amministrazione, bensì mediante la collaborazione dei soggetti interessati, con il conseguente ampliamento della sfera del cd. diritto paritario.
L'interesse legittimo, a sua volta, nelle più recenti elaborazioni dottrinali e giurisprudenziali, non rileva più come situazione meramente processuale, del quale non sarebbe neppure ipotizzabile una lesione produttiva di danno patrimoniale, ma ha anche, al pari del diritto soggettivo, natura sostanziale, configurandosi come "posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente nell'attribuzione al tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio del potere in modo da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene".
Il trasferimento di azienda
L'esame degli interventi normativi e giurisprudenziali succedutisi negli ultimi tempi sul tema del trasferimento di azienda induce a sottolineare la centralità che la persona del lavoratore assume nell'ordinamento giuridico italiano. Molto sentita è l'esigenza di proteggere il prestatore di lavoro dalle rilevanti ripercussioni che sulla sua situazione può avere la decisione del datore di lavoro di trasferire la propria azienda. Se da un lato, quindi, si è riconosciuta all'imprenditore la possibilità di disporre della propria azienda, alla stessa stregua di un qualsiasi altro suo bene, dall'altro sono state introdotte garanzie a favore del lavoratore, considerato tradizionalmente quale parte debole del rapporto di lavoro.
L'annullamento di aggiudicazione di gara pubblica
L'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di gara pubblica e gli effetti sul contratto nelle more stipulato
La problematica relativa ai rapporti tra il procedimento di aggiudicazione di gara pubblica (che si conclude con un provvedimento amministrativo) e il contratto stipulato in esito a detto procedimento si pone come diretta conseguenza della particolare natura dei contratti della pubblica amministrazione, quale fattispecie complessa in cui convergono profili sia pubblicistici che privatistici.
Infatti, mentre in diritto civile la formazione del contratto è lasciata alla libera iniziativa delle parti, salvo il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in diritto amministrativo, per regola, la formazione del contratto è preceduta da un procedimento, cosiddetto ad evidenza pubblica, in cui, in parallelo agli atti o ai procedimenti contrattuali di diritto privato, si svolgono dei procedimenti amministrativi aventi lo scopo di rendere conoscibili, anche mediante controlli, i motivi di pubblico interesse del contratto.
Più specificamente, il procedimento ad evidenza pubblica è un procedimento di procedimenti che si articola in almeno quattro fasi necessarie: la delibera a contrattare, con cui la P.A. dichiara l'intento di addivenire ad un contratto di un certo tipo e contenuto; la scelta del contraente (nelle forme di asta pubblica, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata); l'aggiudicazione-stipulazione ed infine l'approvazione.
Nell'ambito di tale procedimento, una prima classificazione attiene agli atti amministrativi suscettibili di incidere sul contratto stipulato in esito ad esso.
Si distinguono, pertanto, atti privi di rilevanza diretta, atti a rilevanza interna e a atti a rilevanza esterna. Per quanto riguarda i primi, si esclude che abbiano rilevanza diretta rispetto al contratto e quindi possano incidere su di esso, in quanto si tratterebbe di atti con funzione strumentale limitata alle attività interne dell'amministrazione ( quali il progetto di contratto di cui all'art. 5 della legge sulla contabilità dello Stato, i pareri, la mancata iscrizione in bilancio della spesa derivante dalla stipulazione del contratto, ecc.).
Ugualmente, gli atti a rilevanza esterna, essendo atti tipicamente condizionanti l'efficacia del contratto, che possono precedere la stipulazione (autorizzazione) ovvero seguirla (approvazione o visto), inciderebbero sulla sola efficacia del contratto, non sulla sua validità, e pertanto la nullità o l'inesistenza di essi, ovvero la loro rimozione, in sede giurisdizionale o di autotutela, comporterebbe la sola inefficacia del contratto mentre, la mera illegittimità, non rilevata d'ufficio dalla P.A., ne tramite impugnazione, non avrebbe alcun riflesso nemmeno sull'efficacia del contratto.
Un problema di incidenza si pone invece per gli atti a rilevanza intema, ovvero condizionanti la validità del contratto, quali ad esempio la deliberazione di contrarre, l'aggiudicazione, la delega conferita ad un organo amministrativo al fine di concludere il contratto.
Trattandosi di atti indefettibili al fine della legittima genesi del contratto, esisterebbe una sorta di automatica comunicabilità del vizio dell'atto rispetto alla stipulazione.
Sicché, a fronte della nullità dell'atto amministrativo, o della inesistenza di esso, il contratto non potrebbe che essere inficiato dallo stesso vizio.
Allorquando, invece, l'atto fosse illegittimo, il contratto sarebbe attinto da un vizio più tenue, essendo solo annullabile.
Sul piano ermeneutico, il problema dell'interazione tra profili pubblicistici e privatistici (e relativa qualificazione della patologia del contratto stipulato dalla P.A. in conseguenza dell'illegittimità degli atti del procedimento ad evidenza pubblica) ha suscitato in dottrina e giurisprudenza un vivace dibattito che vede a confronto diverse tesi, esemplificativamente riconducibili a cinque distinte categorie:
- la tesi dell'annullabilità relativa ex art. 1441 c.c.;
- la tesi della nullità assoluta;
- la tesi della caducazione automatica;
- la tesi dell'inefficacia ex art. 1398 c.c.;
- la tesi del travolgimento del contratto con salvezza dei diritti dei terzi di buona fede, in applicazione analogica degli artt. 23 co. 2 e 25 co. 2 c.c..
Leggi tutto: L'annullamento di aggiudicazione di gara pubblica
La riforma dell'art. 111 Cost.
Principi naturali del giudizio penale e linee di evoluzione del nuovo sistema processuale alla luce della riforma dell’art. 111 Cost.
Il giudizio penale è governato da una serie di principi fondamentali tra cui particolare rilevanza assumono quelli della contestazione, del contraddittorio, della pubblicità, della oralità, dell’immediatezza, della difesa e del libero convincimento del giudice. Tra essi quello della pubblicità, dell’oralità e del contraddittorio vengono qualificati come “naturali” in quanto immanenti alla società, predicati della sua organizzazione e pertanto delineabili come nuclei storicamente significativi.
La scelta del modello di procedimento penale infatti è significativa del livello di civiltà di un popolo come già rilevava il giurista Mario Pagano nel XVIII secolo: “Il processo fa quel corso medesimo che compiono le nazioni tutte nei diversi loro ma stabili periodi. Le barbare nazioni non conoscono affatto processi, le di loro cause, o si decidono con il ferro o con il parere ed arbitrio di un senato composto dai capi delle nazioni e di un re duce nella guerra e sacerdote nella pace […] Quando poi coltivasi più la società e la barbara civile polita diviene sviluppasi la ragione si stabilisce un moderato governo e vengono fissate le vere idee della libertà civile; si conosce allora la necessità d’un regolare processo; le leggi ne dettano la forma, e ne stabiliscono le utili e necessarie formalità, le quali, frenando l’assoluto arbitrio del giudice, non lasciano luogo alcuno alla perniciosa impunità”.
La penalità moderna, in quanto ragione, dovrebbe, quindi, essere affrancazione progressiva dal modello dell’inquisizione in cui il potere del sovrano si esprime attraverso la segretezza del processo, tendente all’accertamento della verità mediante confessione e la pubblicità esemplare dell’esecuzione della pena. Il ribaltamento progressivo dei criteri della sovranità avrebbe condotto nello stato di diritto al ribaltamento di un simile modello attraverso la pubblicità del processo e la perdita di esemplarità delle pene. A tale proposito non a caso N. Bobbio spiega la dinamica tra visibilità ed invisibilità delle procedure del potere come il metro che dimensiona successi ed insuccessi della democrazia. Al potere, alla democrazia come palazzo, “arcana imperi”, si contrappone la democrazia come piazza, “agorà”, dove le regole delle relazioni e quelle del loro controllo siano visibili e a loro volta controllabili. Da questo punto di vista tra gli esempi storici più significativi di democrazia evoluta si collocano il processo attico, quello romano di epoca repubblicana e quelli nati dalla riforma rivoluzionaria della fine del ‘700.
Pagina 1 di 4